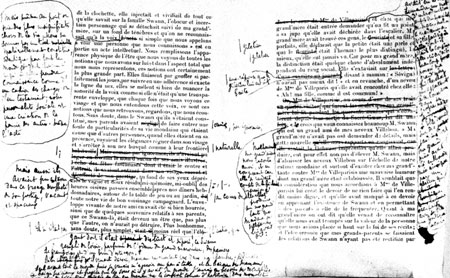Non trovando traccia scritta di una delle Lezioni di design condotte da Ugo Gregoretti – programma Rai, autori Stefano Casciani e Anna Del Gatto, regia Maurizio Malabruzzi – dedicata al tema del Museo del design italiano e di cui rimane invece traccia video negli archivi Rai, ci siam presi la briga di darne trascrizione fedele. Ricavando da questo viaggio nel tempo non poche informazioni e interessanti suggestioni: speranze e disillusioni già provate dai fatti.[intro]Andrea Branzi: “I musei esistono se c’è un curatore, un direttore capace di farli vivere, altrimenti sono delle collezioni che non servono a nessuno.”Giulio Castelli: “Penso che questo museo debba essere il posto, il locale, il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica.”Makio Hasuike: “Non saprei se è tutto negativo la non esistenza di un museo.”Luca Scacchetti: “Non è un dramma che non esista un museo del design, va benissimo andarsi a cercare gli esempi storici su “Casabella” degli anni sessanta; non è importantissimo. È segno di un disastro.”Vittorio Fagone: “Credo che un museo del design in Italia andrebbe fatto.”Hasuike: “Veramente io non so dove mandare i miei amici per vedere le cose di design, non esiste.”Fagone: “Questo museo del design è praticamente forse fatto nelle case di molti italiani.”Castelli: “Il primo museo che ho visto di design naturalmente è stato il MoMA a New York.”Hasuike: “Ho visto il museo di Londra del design, però mi pare che già quello che è stato fatto alla Triennale qualche anno fa è nettamente superiore, a mio modo di vedere.”Branzi: “Oggi indubbiamente credo il museo del design fatto in maniera intelligente sarebbe importante averlo.”Castelli: “Bisogna fare un museo che sia vivo, che sia in movimento; un museo fermo e statico dove la gente passa e guarda i prodotti – specialmente di disegno industriale – mi sembra una cosa ormai superata.”Fagone: “Il museo del design italiano è nella vita di tutti noi, per fortuna.”Ugo Gregoretti: «In Italia, culla del design contemporaneo, non esiste un museo nazionale, centrale, pubblico del design, così come non esiste una sezione del design in alcun museo pubblico italiano di arte contemporanea. I musei di attrezzi agricoli, le raccolte di contadinerie ormai non si contano, pullulano in tutta la penisola; del design, scarse tracce. Mi si è detto che poiché la civiltà contadina è estinta è giusto custodirne le memorie prima che scompaiano. Certo. Ma allora dobbiamo aspettare che si estingua la civiltà urbana, metropolitana, industriale, postindustriale, telematica, futurologica per avere finalmente tra qualche millennio il museo italiano del design. Ma, ci si può obiettare, l’Italia è come risaputo un museo all’aria aperta, lo dicono tutti, e quindi godiamoci all’aria aperta le sedie e i tavolini del caffé, le caffettiere e le lampade, le carrozzerie delle automobili, gli oggetti eleganti esposti nelle vetrine dei negozi, i negozi stessi, disegnati dai nostri eccellenti designer. Che bisogno c’è di metterli ad ammuffire in un museo?»[sigla]UG: «Cominciamo con Paola Antonelli del MoMA di New York. Esiste un rapporto antico tra il suo museo e il design italiano…»Paola Antonelli: «Esiste un rapporto antico tra il museo e il design, antico quanto il museo, perché quando il museo è stato fondato nel 1929 il primo direttore del museo che aveva 27-28 anni a quel tempo, Alfred Barr era il suo nome, era quello che aveva deciso che tra le forme di arte moderna ci dovessero essere la fotografia e il cinema, il design e l’architettura. Il curatore a quel tempo era Philip Johnson – che adesso ha 92 anni ed è ancora pimpante, ancora dice la sua – e fin dall’inizio del museo il design ha fatto parte del catalogo dei capolavori di arte contemporanea mondiali.»UG: «Ci fu una famosa mostra nel 1930…»PA: «Beh quella è una mostra di architettura sull’International style, sull’archiettura modernista internazionale; ma il design italiano ha cominciato a entrare nel museo quando ha cominciato a sbocciare nel mondo. Perché, diciamo, negli anni trenta-quaranta il design italiano era talmente sottile… ci voleva tempo per capirlo, non era ancora veramente protagonista. Negli anni cinquanta e soprattutto con gli anni sessanta la collezione ha cominciato a ingrassarsi di design italiano, finché c’è stata una grande mostra nel 1972 che da molti storici qui presenti è considerata quasi un “canto del cigno” di una certa parte del design italiano, si chiamava Italy. The new domestic landscape, era stata organizzata da un curatore argentino Emilio Ambasz ed era una mostra splendida, in cui c’era tutto il meglio del design italiano degli anni sessanta e dell’inizio settanta.»UG: «E il MoMA ha accolto altri prototipi del design italiano, dopo?»PA: «Sì… usando la parola prototipi, abbiamo molto pochi prototipi, sono quasi tutti pezzi di produzione; ma continuamente, ogni volta che c’è un bel pezzo di design italiano o prodotto in Italia viene considerato per la collezione, quindi anche adesso, sì.»UG: «Quindi c’è speranza anche per i designer delle nuove generazioni di approdare prima o poi al MoMA?»PA: «Scherziamo? Certo! Continuamente.»UG: «Bene, grazie. Il signor Alexander van Vegesack, del Vitra Museum… lei è un collezionista che ha fatto della sua collezione il nucleo, il perno di una raccolta che poi si è sviluppata, si è arricchita…»Alexander van Vegesack: «Ho cominciato molto presto a collezionare mobili, ma all’inizio mi sono particolarmente concentrato a organizzare tutto quello che era la produzione di serie. Subito dopo mi sono immediatamente impegnato in tutte le altre fasi del processo della produzione di mobili: plastica, fibre di vetro e tutte quelle tecniche che noi oggi conosciamo. Quando la collezione ha cominciato a prendere forma io mi sono dato da fare per organizzare le prime mostre, mentre allo stesso tempo cercavo di condurre ricerche sulle fasi del processo produttivo e sul design stesso.»UG: «Lei è anche direttore del museo?»AvV: «Sì, è stata una mia idea fondare il museo e sono quindi responsabile del programma e dell’organizzazione intera del museo.»UG: «La signora Cathy Leff, direttrice del Wolfsonian – ho detto più o meno… così e così… – Museum di Miami, con una attenzione, mi pare di avere capito, particolare alla produzione italiana.»Cathy Leff: «La fondazione Wolfsonian è stata fondata da Mitchell Wolfson Jr.»UG: «… magnate diciamo così…»CL: «… è molto interessante perché ha trascorso parte della sua vita in Italia, sviluppando la carriera diplomatica. Ha cominciato con dei semplicissimi materiali, ha cominciato con gli inizi della produzione industriale e la nostra collezione raggiunge ora il 1945, quindi una parte molto significativa di questa collezione ha una origine italiana.»UG: «Benissimo, grazie. Adesso il primo ospite cosiddetto “su nastro”, l’achitetto e designer Luca Scacchetti.»Luca Scacchetti [testimonianza video]: «Maniacale… mi piacerebbe molto che il museo del design avesse un aspetto maniacale… che riuscisse – non so con quali sistemi, ma l’informatica in questo aiuta molto – proprio a contenere tutto il design fatto, non solo quello di adesso. C’è un bellissimo racconto su un cartografo, di Borges, e racconta come questo cartografo facesse questa carta della Spagna ma sempre a una scala maggiore, ma sempre insoddisfatto dell’imprecisione a contenere tutte le notizie che in realtà in Spagna ci sono. Fin quando alla fine della sua vita riuscirà a disegnare una carta che sovrapponendola alla Spagna corrispondeva esattamente. Cioè aveva disegnato una carta che era grande quanto la Spagna. Così mi piacerebbe che fosse il museo del design.»UG: «Giovanni Pinna, presidente del comitato italiano dell’International Council of Museums. I musei internazionali accolgono, pare di capire, maggiormente la cosiddetta “cultura materiale” e il design rispetto a quelli italiani. È così?»Giovanni Pinna: «Sì questo è abbastanza evidente. Probabilmente deriva dal fatto che gli italiani non sanno riconoscere il valore di quello che fanno. In realtà la comunità deve spingere per la creazione dei musei; i musei si creano di solito dal basso per interesse della società o di elementi della società che collezionano oggetti che testimoniano la loro storia, la loro origine, la loro cultura… Qui quello che sembra è che non ci sia questa spinta a costruire… e questa è una cosa strana per una città come Milano che ha una vocazione in questo campo, e sembra che non riconosca queste sue vocazioni.»UG: «Eh questo sembra un argomento delicato… Comunque vediamo che cosa succede a Milano.»[immagini della mostra Museo del Design – Collezione Permanente del design italiano 1945-1990 della Triennale di Milano]UG: «Ecco oggi questo che era, che è stato per un breve tempo il museo del design della Triennale di Milano non sta più alla Triennale. Non è scomparso, non è che si siano polverizzati questi reperti. Sono stati traslocati e non più, perlomeno, non tanto facilmente accessibili al visitatore medio; se tra i visitatori medi possiamo includerci anche noi come inviati della televisione, in realtà non ci è stato consentito, non è stato consentito al regista con i suoi operatori di filmare questi oggetti, questi mobili, che oggi si trovano al Politecnico. Ecco ora sentiamo l’architetto Giampiero Bosoni, responsabile scientifico della collezione permanente del museo del design della Triennale di Milano. Ecco, ci parli un po’ di queste tormentate vicende e anche del destino futuro della Triennale e della sua collezione.»Giampiero Bosoni: «Sono contento che si siano accennati, nei passaggi anche precedenti, come per esempio nell’intervento di Makio Hasuike – il designer che ha parlato all’inizio della trasmissione – e anche di Andrea Branzi, al fatto che questa collezione esiste e ha potenzialmente delle grandi caratteristiche che a Milano mancano, per quanto ne parlavamo prima con il nostro punto di riferimento, faro storico della critica e della storia del disegno industriale, Gillo Dorfles, da più di quarant’anni, quasi cinquanta, da quando Adriano Olivetti si è fatto portavoce, grande sostenitore della cultura del design italiano, occorresse pensare a un luogo dove poter portare in esposizione, mantenere la cultura storica del design italiano. Mi fa piacere che Makio Hasuike abbia accennato che poi oggi quella collezione storica che la Triennale ha potuto tenere in esposizione per un anno e mezzo – tutto sommato la più lunga esposizione che la Triennale abbia avuto dal 1933 a oggi, quindi è stato comunque un importante contributo – sia rispetto a quella londinese, per esempio secondo Hasuike, comunque un grande patrimonio. Io vi posso parlare molto bene della storia, di come è nata questa collezione, e dirvi quello che a me risulta del suo futuro, perché sicuramente ne ha di futuro. Vorrei dirvi che questa collezione è molto ben esposta, o comunque correttamente esposta su 1600 mq presso la sede, nella sede, potremmo dire, della facoltà nuova di disegno industriale del Politecnico di Milano; e questo fatto, almeno di principio, lo trovo molto buono. Purtroppo è poco visitabile, mi dispiace molto che non lo sia stato per il regista di questa trasmissione. Sta di fatto che quella collezione, che rimane un contributo importante di livello internazionale, esiste e sta crescendo, perché da come era stata tenuta in esposizione presso la Triennale oggi dispone anche di un preziosissimo, nuovo contributo che è la famosa collezione dei modelli storici di Giovanni Sacchi che con accordi avvenuti recentemente è stata in effetti comperata dalla Regione di Milano [sic] e data in deposito – come ulteriore contributo storico – alla collezione storica della Triennale.»UG: «Quindi è importante che Milano si dia questo museo.»GB: «Io direi che c’è una cosa di cui parlavamo, e io ho scritto di questo anche sulle riviste di settore, visto che sono stato uno di quelli che ha forzato certe resistenze perché comunque si potesse portare in esposizione questo patrimonio storico. Dire che questa a oggi in questo momento è una grande potenzialità, è vero quello che dice Branzi che un museo non è solo una collezione, ma io credo per un museo occorre una collezione, che comunque è un elemento forte e importante di questo grande organismo che indubbiamente la Triennale sola non poteva e non è riuscita a sostenere.»UG: «Comunque datevi da fare perché alcuni segni fanno intendere che Roma “ladrona” sia in agguato. È vero Anna Del Gatto, autrice e curatrice del programma che introduce ora l’agguato romano…»Anna Del Gatto: «Sì, Ugo, senti io vorrei interrompere un momento per dire che nel pubblico è arrivato ora Giovanni Sacchi, che era stato citato adesso da Bosoni e quindi volevo fargli un omaggio perché è una persona grande per tutti noi…»[applauso]Giovanni Sacchi: «Potrei dire che sono il museo del design. Io son nato costruendo modelli per fonderie. Poi l’incontro causale [sic] con Nizzoli negli anni cinquanta mi ha portato a trasformarmi nel designer. Posso dire che da me sono passati tutti i designer italiani, specialmente i milanesi – vedo delle facce note che hanno studiato con Nizzoli. Abbiamo creato tanti modelli, abbiamo fatto tanti lavori, abbiamo disperso un patrimonio di lavoro… perché? Non c’è mai stata una raccolta di questo. Cinquant’anni che predico questo museo… non un museo perché è un museo… Nel conservare questo fattore di lavoro che hanno fatto questi designer italiani, che hanno sviluppato nel mondo intiero la loro intelligenza… non si può nascondere: la moda ha fatto il suo passo, ma il design ha fatto di più della moda, perché l’industria italiana con il designer si è evoluta in tutti i campi e fa fede ancora oggi il nostro designer. Vediamo ancora i nostri designer richiesti. Guardate che oggi da me c’erano 40 finlandesi. Perché vengono da me? Perché manca l’incontro scuola e lavoro… Domani io vado in Svizzera, perché mi hanno invitato; e perché questo invito come persona unica? Perché il design italiano è stato lì, messo da parte, non lo abbiamo mai sviluppato per quello che era, per quello che è. E tuttora il designer italiano è alla testa del lavoro italiano. Non c’è un prodotto che non sia disegnato da un designer italiano. E questa è una evoluzione che bisogna conservarla, anche con il museo, partendo naturalmente dai prototipi, dallo studio del lavoro che fa il designer… non è che disegna perfettamente e basta: il designer costruisce man mano che il lavoro nasce; il modello nasce in base all’idea del designer.»UG: «Bene, sentiamo Sandra Pinto, direttrice della Galleria nazionale di arte moderna di Valle Giulia a Roma.»Sandra Pinto [testimonianza video]: «Il progetto vincitore è un progetto che ha perfettamente inteso lo spirito; è un progetto di ingegneria istituzionale altrettanto difficile quanto il tema architettonico. Si tratta infatti adesso di passare da un’idea generale a un’idea di dettaglio e molto precisata su un qualcosa che non è un museo e non è una università ma è un grande centro di produzione della cultura contemporanea, in cui il momento della creazione, il momento dell’informazione, il momento dello scambio interattivo tra l’arte, la società e la cultura si cristallizza il minuto successivo in una forma di memoria e di museo. Certamente è importante che ci si possa confrontare su tutto poi il vasto patrimonio di fatti che interessano la cultura contemporanea. Il centro lo farà con un polo importante per la ricerca e anche per la ricerca avanzata, come pure con gli strumenti da portare a immediata disposizione del pubblico. Sia il progetto architettonico sia il progetto istituzionale lavora su un concetto di navigazione, come se fossimo in una sorta di internet ma in uno spazio reale non in uno spazio virtuale. Le domande da porsi interrelatamente fra una forma artistica e l’altra, fra una disciplina e l’altra, fra un medium e l’altro dovrebbero avvenire nello spazio grande ma non grandissimo di 27.000 mq.»UG: «Il professor Gillo Dorfles, diciamo l’ornamento maggiore di questo incontro di oggi…»Gillo Dorfles: «Non esageriamo, non esageriamo soprattutto…»UG: «No, no, come non esageriamo… Penso siamo tutti d’accordo. Questo mito del design milanese ha ragione di continuare, come dire, nel suo rigoglio?»GD: «Sì per una volta una fama non è usurpata. Bisogna riconoscere che Milano ha avuto la straordinaria fortuna, più che abilità, di inventare il design quando ancora in Italia non si sapeva che cosa fosse. In un certo senso Milano ha fatto il design e solo dopo cinque o sei anni si è accorta che si trattava di design. Molti industriali milanesi avevano degli studi, ricorrevano a professionisti, soprattutto architetti, e non sapevano neanche che la parola “design” volesse dire quello che oggi sappiamo voglia dire. Difatti per molto tempo si è discusso: bisogna dire “disegno industriale” o bisogna dire “design”? Ma a parte questo, non c’è dubbio che Milano da cinquant’anni a questa parte è la capitale del design, è quella che ha dato maggiore apporto, maggiori scoperte formali in questo campo. E difatti anche all’estero quasi tutti riconoscono a Milano questa caratteristica.»UG: «Qual è la peculiarità naturale che consente al design milanese di essere così universale?»GD: «Io credo che è dovuta all’incontro di una sufficiente attenzione alla funzione, alla funzionalità degli oggetti, come del resto anche i giapponesi, gli americani, i tedeschi sanno fare, e una inventiva che è particolare del designer italiano. Quindi questo incontro delle due cose, che a volte ha dato origine anche a degli scontri sanguinosi, ha fatto sì che sono venuti alla luce degli oggetti del tutto particolare che non avrebbero mai potuto avere natali in Germania, o America e neppure in Inghilterra.»UG: «Quindi il design milanese affonda le radici nella grande tradizione italiana…»GD: «… in fondo gli italiani di oggi, che non sono più i grandi pittori del Rinascimento, che non sono più i grandi architetti barocchi, che non sono più i grandi artisti di un millennio, nel campo del design hanno ritrovato le radici che pareva avessero perduto.»UG: «E quindi questo museo del design?»GD: «Eh, qui il problema, perché bisogna intendersi prima di tutto su che cosa è o dovrebbe essere il museo del design. Perché non basta mettere un migliaio di oggetti uno accanto all’altro – cosa che per conto mio è sbagliata – bisogna trovare il modo che il museo del design abbia i prototipi fondamentali ma abbia anche i progetti, abbia anche i disegni esecutivi, abbia anche tutto quell’insieme di materia preparatoria al design che è fondamentale. Per questo prima di dire “museo di design” bisognerebbe decidere come sarà o sarebbe questo design: come il Victoria&Albert Museum o come la raccolta archivio di Quintavalle a Parma? Sono due poli che possono confluire in un museo del design.»UG: «O come il museo di Groningen in Olanda, del quale ora vedremo le immagini e poi così a sorpresa vi diremo chi è e dove sta l’autore.»[immagini del museo di Groningen]UG: «L’autore di questo mitico museo del quale abbiamo assaporato una specie di videoclip è qui seduto accanto a me ed è l’architetto Alessandro Mendini, diciamo, la cui fama è talmente vasta e salda, che è superfluo che io la riconfermi. Ecco, architetto, come è stata l’esperienza della costruzione di questo museo? Lei ha avuto anzitutto un committente nella persona del suo direttore, il soprintendente, il signore [Frans] Haks, con il quale ha in qualche modo concertato l’impostazione…»Alessandro Mendini: «Sì esatto. L’avventura bellissima – il museo adesso ha cinque anni – è cominciata quando questo signor Haks ha suonato il campanello del mio studio e mi ha chiesto di progettargli il museo della città di Groningen, che è un museo che va dalla archeologia a una pinacoteca, a dei padiglioni fino all’arte contemporanea. Appunto perché diviso in padiglioni specializzati è una specie di somma di piccoli musei che danno luogo a un macromuseo, a una sintesi. Sulla base di questa situazione anche proprio urbanistica abbiamo deciso di invitare alcuni architetti ospiti, per cui l’architettura è una somma di architetture contemporanee di diversa caratteristica linguistica e pertanto lo stesso museo si presenta in maniera “automuseale”… come potrei dire…»UG: «Lei è stato l’architetto padre…»AM: «Sono il coordinatore generale di tutta questa cosa complessa.»UG: «… che ha ricostituito intorno a questa impresa quello che ‘è il suo habitat naturale di lavoro, che è l’atelier.»AM: «Sì, io sono abituato e mi interessa anche molto lavorare con persone diverse, nel senso che abbiano la testa anche molto diversa dalla mia, e pertanto i miei lavori in genere sono dei patchwork…»UG: «… però lei ha detto “purché imparino l’alfabeto” cioè l’alfabeto di Mendini…»AM: «Beh sì, c’è di mezzo evidentemente una specie di necessità di sintesi per arrivare a un obiettivo che rimane però sempre un po’ aperto perché non si ha mai l’ultima parola nel momento in cui lavorano creativamente anche gli altri.»UG: «Ed è stato edificato su un’isola artificiale al centro di un canale altrettanto artificiale.»AM: «Sì, come succede in Olanda, questo museo è nell’acqua, è un’isola fra due ponti dei quali uno levatoio perché tanto passano le navi; si stanno progettando probabilmente anche dei padiglioni a zattera che possono arrivare anche magari a Amsterdam o più lontano…»UG: «Le piacerebbe costruire il museo del design di Milano?»AM: «No. Io mi sono occupato del museo… di musei di design a Milano, penso, per trent’anni: ogni anno ne saltava fuori uno; ho cominciato con Gio Ponti e con Roberto Olivetti, e con Dorfles anche, e progressivamente mi sono assolutamente defaticato e non mi interessa sentire parlare di museo di design a Milano.»UG: «Mentre invece altrove sì?»AM: «Dove c’è qualche speranza, perché qui la speranza, secondo me, nonostante quello che dice Bosoni non c’è.»UG: «Ho capito. Sentiamo adesso un’altra rapida testimonianza di un ospite “riprodotto”, Vittorio Fagone, critico d’arte e direttore della galleria, della Pinacoteca dell’Accademia Carrara di Bergamo.»Vittorio Fagone [testimonianza video]: «Quando nel 1995 ho potuto dedicare una mostra a Gianni e Joe Colombo, lo sconcerto di alcuni visitatori che, abituati a visitare uno spazio museale vi trovavano esposti degli oggetti, e qualcuno diceva “Mah, il museo è diventato la Rinascente”, questo dato di contemporaneità, a mio giudizio, contemporaneità in cui si trovano il fruitore e il progettista, è il dato più affascinante dell’universo del design.»UG: «Stefano Casciani, giornalista, esperto di design e architetto coautore del nostro programma. Come mai gli architetti italiani costruiscono musei all’estero e i nostri musei vengono progettati dagli stranieri, per esempio l’architetta [sic] Aziz [sic] [2xsic=sigh] che ha vinto il concorso per il nuovo centro di arte contemporanea romano.»Stefano Casciani: «Questa che tu sollevi è una polemica ormai di livello internazionale. Ho scovato l’altro giorno su internet una notizia deliziosa a proposito delle polemiche che stanno sorgendo negli stati uniti a Chicago perché Renzo Piano ha vinto un concorso internazionale per l’estensione dell’Art Institute di Chicago, che è uno dei musei più belli degli Stati Uniti. Negli stessi giorni iniziava anche a serpeggiare una polemica anche piuttosto pesante fatta da alcuni baroni dell’architettura italiana contro Zaha Hadid che ha avuto il coraggio di vincere il concorso per il centro internazionale delle arti contemporanee di Roma. Io credo che di fronte al fenomeno della globalizzazione tutte queste polemiche siano piuttosto ridicole e vogliano soltanto cercare di mantenere un impossibile equilibrio geografico culturale. Quindi mi sembra che il problema del museo ritorni comunque sulla centralità del problema dell’oggetto. Studiando questo problema per questa mostra con la galleria nazionale delle arti moderne di Roma, il dato interessante è proprio quello del ritorno del pubblico all’interesse verso l’oggetto. Paola Antonelli ha organizzato per il Museum of Modern Art di New York una mostra di Achille Castiglioni che ha avuto 100mila visitatori. Con Alessandro Mendini abbiamo realizzato una mostra al Louisiana Museum di Copenaghen sul design italiano e sul design europeo che ha avuto 106mila visitatori in tre mesi. Questi mi sembrano dati comunque positivi e interessanti, è forse su questo che ci dobbiamo concentrare per capire l’attualità e centralità dello specifico degli oggetti nei musei.»UG: «Franco Origoni, graphic designer, anche lei è d’accordo sulla necessità che si istituisca un msueo del design.»Franco Origoni: «Per fare il museo del design secondo me bisogna ricordarsi di un pezzettino che c’è in Nuovo cinema Paradiso di Tornatore, dove al ragazzo che ha nostalgia della Sicilia gli si dice “non ti voltare mai e vai avanti”. Cioè se vogliamo fare un museo del design in Italia è chiaro dobbiamo dimenticarci delle logiche che si intrecciano e che hanno impedito al museo di vivere. Ci sono le collezioni di design ormai diffuse; se citiamo oltre alle collezioni particolari dell’Alessi, c’è l’Alfa Romeo, c’è la Fiat, c’è la Caproni, ci sono una quantità di aziende che prima che fosse fatta la legge e dopo hanno messo insieme le loro collezioni… per cui quello che manca è un motore che ragioni sulla natura del design, sul ruolo del design e su che cosa è il design oggi. Non è un luogo fisico, il luogo fisico c’è e se ne trova… c’è una collezione straordinaria che va rivalutata.»UG: «E le cause che fino a oggi hanno impedito la realizzazione di questo…»FO: «Beh la concezione innanzi tutto del museo ottocentesco. Non voglio fare adesso una disquisizione filosofica su questa cosa però se si pensa che i musei di design sono una sequenza di oggetti esposti in maniera stabile in una teca fantastica, illuminati con una illuminazione bellissima, questo è un museo che è morto già dall’inizio. Il museo è un pezzo di serie, e non è comunque anche quando è un segno molto forte un pezzo unico come può essere un Piero della Francesca. Il rapporto nei musei d’arte – credo che Paola Antonelli ne sappia più di me – fra la parte di collezione e la parte esposta in maniera permanente si calcola nella progettazione dei musei nel rapporto di uno a cinque, cioè se ci sono mille metri quadri di esposizione ce ne sono cinquemila di organizzazione per fare funzionare il museo. Ci sono equipe che fanno funzionare il museo, che fanno ruotare le mostre sulla stessa collezione… Forse a questo bisognerebbe pensare, non alle polemiche che inseguiamo tutti i giorni.»UG: «Bene. Chiudiamo con un’ultima testimonianza registrata. Giulio Castelli, imprenditore: il museo del design che vorrebbe.»Giulio Castelli: «È molto più interessante avere un museo virtuale. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia del design, di un designer, e dei disegni tecnici di questo prodotto, e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti per poterlo guardare realmente. Ecco questo sarebbe secondo me l’ideale. Forse con i mezzi futuri, visto che si fanno i magazzini che schiacciando i bottoni si fanno le spedizioni, perché non si deve poter avere un magazzino dove schiacciando un bottone ci sia un nastro, un tapis roulant che porti questo pezzo davanti allo studente o al ricercatore o allo studioso.»
Non trovando traccia scritta di una delle Lezioni di design condotte da Ugo Gregoretti – programma Rai, autori Stefano Casciani e Anna Del Gatto, regia Maurizio Malabruzzi – dedicata al tema del Museo del design italiano e di cui rimane invece traccia video negli archivi Rai, ci siam presi la briga di darne trascrizione fedele. Ricavando da questo viaggio nel tempo non poche informazioni e interessanti suggestioni: speranze e disillusioni già provate dai fatti.[intro]Andrea Branzi: “I musei esistono se c’è un curatore, un direttore capace di farli vivere, altrimenti sono delle collezioni che non servono a nessuno.”Giulio Castelli: “Penso che questo museo debba essere il posto, il locale, il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica.”Makio Hasuike: “Non saprei se è tutto negativo la non esistenza di un museo.”Luca Scacchetti: “Non è un dramma che non esista un museo del design, va benissimo andarsi a cercare gli esempi storici su “Casabella” degli anni sessanta; non è importantissimo. È segno di un disastro.”Vittorio Fagone: “Credo che un museo del design in Italia andrebbe fatto.”Hasuike: “Veramente io non so dove mandare i miei amici per vedere le cose di design, non esiste.”Fagone: “Questo museo del design è praticamente forse fatto nelle case di molti italiani.”Castelli: “Il primo museo che ho visto di design naturalmente è stato il MoMA a New York.”Hasuike: “Ho visto il museo di Londra del design, però mi pare che già quello che è stato fatto alla Triennale qualche anno fa è nettamente superiore, a mio modo di vedere.”Branzi: “Oggi indubbiamente credo il museo del design fatto in maniera intelligente sarebbe importante averlo.”Castelli: “Bisogna fare un museo che sia vivo, che sia in movimento; un museo fermo e statico dove la gente passa e guarda i prodotti – specialmente di disegno industriale – mi sembra una cosa ormai superata.”Fagone: “Il museo del design italiano è nella vita di tutti noi, per fortuna.”Ugo Gregoretti: «In Italia, culla del design contemporaneo, non esiste un museo nazionale, centrale, pubblico del design, così come non esiste una sezione del design in alcun museo pubblico italiano di arte contemporanea. I musei di attrezzi agricoli, le raccolte di contadinerie ormai non si contano, pullulano in tutta la penisola; del design, scarse tracce. Mi si è detto che poiché la civiltà contadina è estinta è giusto custodirne le memorie prima che scompaiano. Certo. Ma allora dobbiamo aspettare che si estingua la civiltà urbana, metropolitana, industriale, postindustriale, telematica, futurologica per avere finalmente tra qualche millennio il museo italiano del design. Ma, ci si può obiettare, l’Italia è come risaputo un museo all’aria aperta, lo dicono tutti, e quindi godiamoci all’aria aperta le sedie e i tavolini del caffé, le caffettiere e le lampade, le carrozzerie delle automobili, gli oggetti eleganti esposti nelle vetrine dei negozi, i negozi stessi, disegnati dai nostri eccellenti designer. Che bisogno c’è di metterli ad ammuffire in un museo?»[sigla]UG: «Cominciamo con Paola Antonelli del MoMA di New York. Esiste un rapporto antico tra il suo museo e il design italiano…»Paola Antonelli: «Esiste un rapporto antico tra il museo e il design, antico quanto il museo, perché quando il museo è stato fondato nel 1929 il primo direttore del museo che aveva 27-28 anni a quel tempo, Alfred Barr era il suo nome, era quello che aveva deciso che tra le forme di arte moderna ci dovessero essere la fotografia e il cinema, il design e l’architettura. Il curatore a quel tempo era Philip Johnson – che adesso ha 92 anni ed è ancora pimpante, ancora dice la sua – e fin dall’inizio del museo il design ha fatto parte del catalogo dei capolavori di arte contemporanea mondiali.»UG: «Ci fu una famosa mostra nel 1930…»PA: «Beh quella è una mostra di architettura sull’International style, sull’archiettura modernista internazionale; ma il design italiano ha cominciato a entrare nel museo quando ha cominciato a sbocciare nel mondo. Perché, diciamo, negli anni trenta-quaranta il design italiano era talmente sottile… ci voleva tempo per capirlo, non era ancora veramente protagonista. Negli anni cinquanta e soprattutto con gli anni sessanta la collezione ha cominciato a ingrassarsi di design italiano, finché c’è stata una grande mostra nel 1972 che da molti storici qui presenti è considerata quasi un “canto del cigno” di una certa parte del design italiano, si chiamava Italy. The new domestic landscape, era stata organizzata da un curatore argentino Emilio Ambasz ed era una mostra splendida, in cui c’era tutto il meglio del design italiano degli anni sessanta e dell’inizio settanta.»UG: «E il MoMA ha accolto altri prototipi del design italiano, dopo?»PA: «Sì… usando la parola prototipi, abbiamo molto pochi prototipi, sono quasi tutti pezzi di produzione; ma continuamente, ogni volta che c’è un bel pezzo di design italiano o prodotto in Italia viene considerato per la collezione, quindi anche adesso, sì.»UG: «Quindi c’è speranza anche per i designer delle nuove generazioni di approdare prima o poi al MoMA?»PA: «Scherziamo? Certo! Continuamente.»UG: «Bene, grazie. Il signor Alexander van Vegesack, del Vitra Museum… lei è un collezionista che ha fatto della sua collezione il nucleo, il perno di una raccolta che poi si è sviluppata, si è arricchita…»Alexander van Vegesack: «Ho cominciato molto presto a collezionare mobili, ma all’inizio mi sono particolarmente concentrato a organizzare tutto quello che era la produzione di serie. Subito dopo mi sono immediatamente impegnato in tutte le altre fasi del processo della produzione di mobili: plastica, fibre di vetro e tutte quelle tecniche che noi oggi conosciamo. Quando la collezione ha cominciato a prendere forma io mi sono dato da fare per organizzare le prime mostre, mentre allo stesso tempo cercavo di condurre ricerche sulle fasi del processo produttivo e sul design stesso.»UG: «Lei è anche direttore del museo?»AvV: «Sì, è stata una mia idea fondare il museo e sono quindi responsabile del programma e dell’organizzazione intera del museo.»UG: «La signora Cathy Leff, direttrice del Wolfsonian – ho detto più o meno… così e così… – Museum di Miami, con una attenzione, mi pare di avere capito, particolare alla produzione italiana.»Cathy Leff: «La fondazione Wolfsonian è stata fondata da Mitchell Wolfson Jr.»UG: «… magnate diciamo così…»CL: «… è molto interessante perché ha trascorso parte della sua vita in Italia, sviluppando la carriera diplomatica. Ha cominciato con dei semplicissimi materiali, ha cominciato con gli inizi della produzione industriale e la nostra collezione raggiunge ora il 1945, quindi una parte molto significativa di questa collezione ha una origine italiana.»UG: «Benissimo, grazie. Adesso il primo ospite cosiddetto “su nastro”, l’achitetto e designer Luca Scacchetti.»Luca Scacchetti [testimonianza video]: «Maniacale… mi piacerebbe molto che il museo del design avesse un aspetto maniacale… che riuscisse – non so con quali sistemi, ma l’informatica in questo aiuta molto – proprio a contenere tutto il design fatto, non solo quello di adesso. C’è un bellissimo racconto su un cartografo, di Borges, e racconta come questo cartografo facesse questa carta della Spagna ma sempre a una scala maggiore, ma sempre insoddisfatto dell’imprecisione a contenere tutte le notizie che in realtà in Spagna ci sono. Fin quando alla fine della sua vita riuscirà a disegnare una carta che sovrapponendola alla Spagna corrispondeva esattamente. Cioè aveva disegnato una carta che era grande quanto la Spagna. Così mi piacerebbe che fosse il museo del design.»UG: «Giovanni Pinna, presidente del comitato italiano dell’International Council of Museums. I musei internazionali accolgono, pare di capire, maggiormente la cosiddetta “cultura materiale” e il design rispetto a quelli italiani. È così?»Giovanni Pinna: «Sì questo è abbastanza evidente. Probabilmente deriva dal fatto che gli italiani non sanno riconoscere il valore di quello che fanno. In realtà la comunità deve spingere per la creazione dei musei; i musei si creano di solito dal basso per interesse della società o di elementi della società che collezionano oggetti che testimoniano la loro storia, la loro origine, la loro cultura… Qui quello che sembra è che non ci sia questa spinta a costruire… e questa è una cosa strana per una città come Milano che ha una vocazione in questo campo, e sembra che non riconosca queste sue vocazioni.»UG: «Eh questo sembra un argomento delicato… Comunque vediamo che cosa succede a Milano.»[immagini della mostra Museo del Design – Collezione Permanente del design italiano 1945-1990 della Triennale di Milano]UG: «Ecco oggi questo che era, che è stato per un breve tempo il museo del design della Triennale di Milano non sta più alla Triennale. Non è scomparso, non è che si siano polverizzati questi reperti. Sono stati traslocati e non più, perlomeno, non tanto facilmente accessibili al visitatore medio; se tra i visitatori medi possiamo includerci anche noi come inviati della televisione, in realtà non ci è stato consentito, non è stato consentito al regista con i suoi operatori di filmare questi oggetti, questi mobili, che oggi si trovano al Politecnico. Ecco ora sentiamo l’architetto Giampiero Bosoni, responsabile scientifico della collezione permanente del museo del design della Triennale di Milano. Ecco, ci parli un po’ di queste tormentate vicende e anche del destino futuro della Triennale e della sua collezione.»Giampiero Bosoni: «Sono contento che si siano accennati, nei passaggi anche precedenti, come per esempio nell’intervento di Makio Hasuike – il designer che ha parlato all’inizio della trasmissione – e anche di Andrea Branzi, al fatto che questa collezione esiste e ha potenzialmente delle grandi caratteristiche che a Milano mancano, per quanto ne parlavamo prima con il nostro punto di riferimento, faro storico della critica e della storia del disegno industriale, Gillo Dorfles, da più di quarant’anni, quasi cinquanta, da quando Adriano Olivetti si è fatto portavoce, grande sostenitore della cultura del design italiano, occorresse pensare a un luogo dove poter portare in esposizione, mantenere la cultura storica del design italiano. Mi fa piacere che Makio Hasuike abbia accennato che poi oggi quella collezione storica che la Triennale ha potuto tenere in esposizione per un anno e mezzo – tutto sommato la più lunga esposizione che la Triennale abbia avuto dal 1933 a oggi, quindi è stato comunque un importante contributo – sia rispetto a quella londinese, per esempio secondo Hasuike, comunque un grande patrimonio. Io vi posso parlare molto bene della storia, di come è nata questa collezione, e dirvi quello che a me risulta del suo futuro, perché sicuramente ne ha di futuro. Vorrei dirvi che questa collezione è molto ben esposta, o comunque correttamente esposta su 1600 mq presso la sede, nella sede, potremmo dire, della facoltà nuova di disegno industriale del Politecnico di Milano; e questo fatto, almeno di principio, lo trovo molto buono. Purtroppo è poco visitabile, mi dispiace molto che non lo sia stato per il regista di questa trasmissione. Sta di fatto che quella collezione, che rimane un contributo importante di livello internazionale, esiste e sta crescendo, perché da come era stata tenuta in esposizione presso la Triennale oggi dispone anche di un preziosissimo, nuovo contributo che è la famosa collezione dei modelli storici di Giovanni Sacchi che con accordi avvenuti recentemente è stata in effetti comperata dalla Regione di Milano [sic] e data in deposito – come ulteriore contributo storico – alla collezione storica della Triennale.»UG: «Quindi è importante che Milano si dia questo museo.»GB: «Io direi che c’è una cosa di cui parlavamo, e io ho scritto di questo anche sulle riviste di settore, visto che sono stato uno di quelli che ha forzato certe resistenze perché comunque si potesse portare in esposizione questo patrimonio storico. Dire che questa a oggi in questo momento è una grande potenzialità, è vero quello che dice Branzi che un museo non è solo una collezione, ma io credo per un museo occorre una collezione, che comunque è un elemento forte e importante di questo grande organismo che indubbiamente la Triennale sola non poteva e non è riuscita a sostenere.»UG: «Comunque datevi da fare perché alcuni segni fanno intendere che Roma “ladrona” sia in agguato. È vero Anna Del Gatto, autrice e curatrice del programma che introduce ora l’agguato romano…»Anna Del Gatto: «Sì, Ugo, senti io vorrei interrompere un momento per dire che nel pubblico è arrivato ora Giovanni Sacchi, che era stato citato adesso da Bosoni e quindi volevo fargli un omaggio perché è una persona grande per tutti noi…»[applauso]Giovanni Sacchi: «Potrei dire che sono il museo del design. Io son nato costruendo modelli per fonderie. Poi l’incontro causale [sic] con Nizzoli negli anni cinquanta mi ha portato a trasformarmi nel designer. Posso dire che da me sono passati tutti i designer italiani, specialmente i milanesi – vedo delle facce note che hanno studiato con Nizzoli. Abbiamo creato tanti modelli, abbiamo fatto tanti lavori, abbiamo disperso un patrimonio di lavoro… perché? Non c’è mai stata una raccolta di questo. Cinquant’anni che predico questo museo… non un museo perché è un museo… Nel conservare questo fattore di lavoro che hanno fatto questi designer italiani, che hanno sviluppato nel mondo intiero la loro intelligenza… non si può nascondere: la moda ha fatto il suo passo, ma il design ha fatto di più della moda, perché l’industria italiana con il designer si è evoluta in tutti i campi e fa fede ancora oggi il nostro designer. Vediamo ancora i nostri designer richiesti. Guardate che oggi da me c’erano 40 finlandesi. Perché vengono da me? Perché manca l’incontro scuola e lavoro… Domani io vado in Svizzera, perché mi hanno invitato; e perché questo invito come persona unica? Perché il design italiano è stato lì, messo da parte, non lo abbiamo mai sviluppato per quello che era, per quello che è. E tuttora il designer italiano è alla testa del lavoro italiano. Non c’è un prodotto che non sia disegnato da un designer italiano. E questa è una evoluzione che bisogna conservarla, anche con il museo, partendo naturalmente dai prototipi, dallo studio del lavoro che fa il designer… non è che disegna perfettamente e basta: il designer costruisce man mano che il lavoro nasce; il modello nasce in base all’idea del designer.»UG: «Bene, sentiamo Sandra Pinto, direttrice della Galleria nazionale di arte moderna di Valle Giulia a Roma.»Sandra Pinto [testimonianza video]: «Il progetto vincitore è un progetto che ha perfettamente inteso lo spirito; è un progetto di ingegneria istituzionale altrettanto difficile quanto il tema architettonico. Si tratta infatti adesso di passare da un’idea generale a un’idea di dettaglio e molto precisata su un qualcosa che non è un museo e non è una università ma è un grande centro di produzione della cultura contemporanea, in cui il momento della creazione, il momento dell’informazione, il momento dello scambio interattivo tra l’arte, la società e la cultura si cristallizza il minuto successivo in una forma di memoria e di museo. Certamente è importante che ci si possa confrontare su tutto poi il vasto patrimonio di fatti che interessano la cultura contemporanea. Il centro lo farà con un polo importante per la ricerca e anche per la ricerca avanzata, come pure con gli strumenti da portare a immediata disposizione del pubblico. Sia il progetto architettonico sia il progetto istituzionale lavora su un concetto di navigazione, come se fossimo in una sorta di internet ma in uno spazio reale non in uno spazio virtuale. Le domande da porsi interrelatamente fra una forma artistica e l’altra, fra una disciplina e l’altra, fra un medium e l’altro dovrebbero avvenire nello spazio grande ma non grandissimo di 27.000 mq.»UG: «Il professor Gillo Dorfles, diciamo l’ornamento maggiore di questo incontro di oggi…»Gillo Dorfles: «Non esageriamo, non esageriamo soprattutto…»UG: «No, no, come non esageriamo… Penso siamo tutti d’accordo. Questo mito del design milanese ha ragione di continuare, come dire, nel suo rigoglio?»GD: «Sì per una volta una fama non è usurpata. Bisogna riconoscere che Milano ha avuto la straordinaria fortuna, più che abilità, di inventare il design quando ancora in Italia non si sapeva che cosa fosse. In un certo senso Milano ha fatto il design e solo dopo cinque o sei anni si è accorta che si trattava di design. Molti industriali milanesi avevano degli studi, ricorrevano a professionisti, soprattutto architetti, e non sapevano neanche che la parola “design” volesse dire quello che oggi sappiamo voglia dire. Difatti per molto tempo si è discusso: bisogna dire “disegno industriale” o bisogna dire “design”? Ma a parte questo, non c’è dubbio che Milano da cinquant’anni a questa parte è la capitale del design, è quella che ha dato maggiore apporto, maggiori scoperte formali in questo campo. E difatti anche all’estero quasi tutti riconoscono a Milano questa caratteristica.»UG: «Qual è la peculiarità naturale che consente al design milanese di essere così universale?»GD: «Io credo che è dovuta all’incontro di una sufficiente attenzione alla funzione, alla funzionalità degli oggetti, come del resto anche i giapponesi, gli americani, i tedeschi sanno fare, e una inventiva che è particolare del designer italiano. Quindi questo incontro delle due cose, che a volte ha dato origine anche a degli scontri sanguinosi, ha fatto sì che sono venuti alla luce degli oggetti del tutto particolare che non avrebbero mai potuto avere natali in Germania, o America e neppure in Inghilterra.»UG: «Quindi il design milanese affonda le radici nella grande tradizione italiana…»GD: «… in fondo gli italiani di oggi, che non sono più i grandi pittori del Rinascimento, che non sono più i grandi architetti barocchi, che non sono più i grandi artisti di un millennio, nel campo del design hanno ritrovato le radici che pareva avessero perduto.»UG: «E quindi questo museo del design?»GD: «Eh, qui il problema, perché bisogna intendersi prima di tutto su che cosa è o dovrebbe essere il museo del design. Perché non basta mettere un migliaio di oggetti uno accanto all’altro – cosa che per conto mio è sbagliata – bisogna trovare il modo che il museo del design abbia i prototipi fondamentali ma abbia anche i progetti, abbia anche i disegni esecutivi, abbia anche tutto quell’insieme di materia preparatoria al design che è fondamentale. Per questo prima di dire “museo di design” bisognerebbe decidere come sarà o sarebbe questo design: come il Victoria&Albert Museum o come la raccolta archivio di Quintavalle a Parma? Sono due poli che possono confluire in un museo del design.»UG: «O come il museo di Groningen in Olanda, del quale ora vedremo le immagini e poi così a sorpresa vi diremo chi è e dove sta l’autore.»[immagini del museo di Groningen]UG: «L’autore di questo mitico museo del quale abbiamo assaporato una specie di videoclip è qui seduto accanto a me ed è l’architetto Alessandro Mendini, diciamo, la cui fama è talmente vasta e salda, che è superfluo che io la riconfermi. Ecco, architetto, come è stata l’esperienza della costruzione di questo museo? Lei ha avuto anzitutto un committente nella persona del suo direttore, il soprintendente, il signore [Frans] Haks, con il quale ha in qualche modo concertato l’impostazione…»Alessandro Mendini: «Sì esatto. L’avventura bellissima – il museo adesso ha cinque anni – è cominciata quando questo signor Haks ha suonato il campanello del mio studio e mi ha chiesto di progettargli il museo della città di Groningen, che è un museo che va dalla archeologia a una pinacoteca, a dei padiglioni fino all’arte contemporanea. Appunto perché diviso in padiglioni specializzati è una specie di somma di piccoli musei che danno luogo a un macromuseo, a una sintesi. Sulla base di questa situazione anche proprio urbanistica abbiamo deciso di invitare alcuni architetti ospiti, per cui l’architettura è una somma di architetture contemporanee di diversa caratteristica linguistica e pertanto lo stesso museo si presenta in maniera “automuseale”… come potrei dire…»UG: «Lei è stato l’architetto padre…»AM: «Sono il coordinatore generale di tutta questa cosa complessa.»UG: «… che ha ricostituito intorno a questa impresa quello che ‘è il suo habitat naturale di lavoro, che è l’atelier.»AM: «Sì, io sono abituato e mi interessa anche molto lavorare con persone diverse, nel senso che abbiano la testa anche molto diversa dalla mia, e pertanto i miei lavori in genere sono dei patchwork…»UG: «… però lei ha detto “purché imparino l’alfabeto” cioè l’alfabeto di Mendini…»AM: «Beh sì, c’è di mezzo evidentemente una specie di necessità di sintesi per arrivare a un obiettivo che rimane però sempre un po’ aperto perché non si ha mai l’ultima parola nel momento in cui lavorano creativamente anche gli altri.»UG: «Ed è stato edificato su un’isola artificiale al centro di un canale altrettanto artificiale.»AM: «Sì, come succede in Olanda, questo museo è nell’acqua, è un’isola fra due ponti dei quali uno levatoio perché tanto passano le navi; si stanno progettando probabilmente anche dei padiglioni a zattera che possono arrivare anche magari a Amsterdam o più lontano…»UG: «Le piacerebbe costruire il museo del design di Milano?»AM: «No. Io mi sono occupato del museo… di musei di design a Milano, penso, per trent’anni: ogni anno ne saltava fuori uno; ho cominciato con Gio Ponti e con Roberto Olivetti, e con Dorfles anche, e progressivamente mi sono assolutamente defaticato e non mi interessa sentire parlare di museo di design a Milano.»UG: «Mentre invece altrove sì?»AM: «Dove c’è qualche speranza, perché qui la speranza, secondo me, nonostante quello che dice Bosoni non c’è.»UG: «Ho capito. Sentiamo adesso un’altra rapida testimonianza di un ospite “riprodotto”, Vittorio Fagone, critico d’arte e direttore della galleria, della Pinacoteca dell’Accademia Carrara di Bergamo.»Vittorio Fagone [testimonianza video]: «Quando nel 1995 ho potuto dedicare una mostra a Gianni e Joe Colombo, lo sconcerto di alcuni visitatori che, abituati a visitare uno spazio museale vi trovavano esposti degli oggetti, e qualcuno diceva “Mah, il museo è diventato la Rinascente”, questo dato di contemporaneità, a mio giudizio, contemporaneità in cui si trovano il fruitore e il progettista, è il dato più affascinante dell’universo del design.»UG: «Stefano Casciani, giornalista, esperto di design e architetto coautore del nostro programma. Come mai gli architetti italiani costruiscono musei all’estero e i nostri musei vengono progettati dagli stranieri, per esempio l’architetta [sic] Aziz [sic] [2xsic=sigh] che ha vinto il concorso per il nuovo centro di arte contemporanea romano.»Stefano Casciani: «Questa che tu sollevi è una polemica ormai di livello internazionale. Ho scovato l’altro giorno su internet una notizia deliziosa a proposito delle polemiche che stanno sorgendo negli stati uniti a Chicago perché Renzo Piano ha vinto un concorso internazionale per l’estensione dell’Art Institute di Chicago, che è uno dei musei più belli degli Stati Uniti. Negli stessi giorni iniziava anche a serpeggiare una polemica anche piuttosto pesante fatta da alcuni baroni dell’architettura italiana contro Zaha Hadid che ha avuto il coraggio di vincere il concorso per il centro internazionale delle arti contemporanee di Roma. Io credo che di fronte al fenomeno della globalizzazione tutte queste polemiche siano piuttosto ridicole e vogliano soltanto cercare di mantenere un impossibile equilibrio geografico culturale. Quindi mi sembra che il problema del museo ritorni comunque sulla centralità del problema dell’oggetto. Studiando questo problema per questa mostra con la galleria nazionale delle arti moderne di Roma, il dato interessante è proprio quello del ritorno del pubblico all’interesse verso l’oggetto. Paola Antonelli ha organizzato per il Museum of Modern Art di New York una mostra di Achille Castiglioni che ha avuto 100mila visitatori. Con Alessandro Mendini abbiamo realizzato una mostra al Louisiana Museum di Copenaghen sul design italiano e sul design europeo che ha avuto 106mila visitatori in tre mesi. Questi mi sembrano dati comunque positivi e interessanti, è forse su questo che ci dobbiamo concentrare per capire l’attualità e centralità dello specifico degli oggetti nei musei.»UG: «Franco Origoni, graphic designer, anche lei è d’accordo sulla necessità che si istituisca un msueo del design.»Franco Origoni: «Per fare il museo del design secondo me bisogna ricordarsi di un pezzettino che c’è in Nuovo cinema Paradiso di Tornatore, dove al ragazzo che ha nostalgia della Sicilia gli si dice “non ti voltare mai e vai avanti”. Cioè se vogliamo fare un museo del design in Italia è chiaro dobbiamo dimenticarci delle logiche che si intrecciano e che hanno impedito al museo di vivere. Ci sono le collezioni di design ormai diffuse; se citiamo oltre alle collezioni particolari dell’Alessi, c’è l’Alfa Romeo, c’è la Fiat, c’è la Caproni, ci sono una quantità di aziende che prima che fosse fatta la legge e dopo hanno messo insieme le loro collezioni… per cui quello che manca è un motore che ragioni sulla natura del design, sul ruolo del design e su che cosa è il design oggi. Non è un luogo fisico, il luogo fisico c’è e se ne trova… c’è una collezione straordinaria che va rivalutata.»UG: «E le cause che fino a oggi hanno impedito la realizzazione di questo…»FO: «Beh la concezione innanzi tutto del museo ottocentesco. Non voglio fare adesso una disquisizione filosofica su questa cosa però se si pensa che i musei di design sono una sequenza di oggetti esposti in maniera stabile in una teca fantastica, illuminati con una illuminazione bellissima, questo è un museo che è morto già dall’inizio. Il museo è un pezzo di serie, e non è comunque anche quando è un segno molto forte un pezzo unico come può essere un Piero della Francesca. Il rapporto nei musei d’arte – credo che Paola Antonelli ne sappia più di me – fra la parte di collezione e la parte esposta in maniera permanente si calcola nella progettazione dei musei nel rapporto di uno a cinque, cioè se ci sono mille metri quadri di esposizione ce ne sono cinquemila di organizzazione per fare funzionare il museo. Ci sono equipe che fanno funzionare il museo, che fanno ruotare le mostre sulla stessa collezione… Forse a questo bisognerebbe pensare, non alle polemiche che inseguiamo tutti i giorni.»UG: «Bene. Chiudiamo con un’ultima testimonianza registrata. Giulio Castelli, imprenditore: il museo del design che vorrebbe.»Giulio Castelli: «È molto più interessante avere un museo virtuale. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia del design, di un designer, e dei disegni tecnici di questo prodotto, e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti per poterlo guardare realmente. Ecco questo sarebbe secondo me l’ideale. Forse con i mezzi futuri, visto che si fanno i magazzini che schiacciando i bottoni si fanno le spedizioni, perché non si deve poter avere un magazzino dove schiacciando un bottone ci sia un nastro, un tapis roulant che porti questo pezzo davanti allo studente o al ricercatore o allo studioso.»